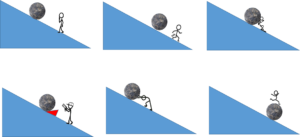(C'è un altro tweet molto simile attribuito a Burioni che gira sul Web. Sembra che entrambi siano autentici, anche se non ne possiamo essere sicuri al 100%. In ogni caso, sono in linea con il pensiero e il modo di fare del personaggio e non sono stati smentiti)
Il tweet di Roberto Burioni riportato qui sopra è andato virale su molti social, dove è stato commentato con insulti e accidenti all'autore. La reazione del pubblico è comprensibile di fronte a un'affermazione che contrasta così platealmente con la linea che Burioni e altri avevano sostenuto fino ad ora, ovvero "fidatevi della scienza, sappiamo noi cosa fare." Invece, questo tweet è una discreta zappata sui piedi (o lesione ad altre parti delicate del corpo) per tutti i televirologi che hanno imperversato negli ultimi 3 anni.
Burioni si trova in evidente difficoltà, costretto in difesa, cercando di giustificare i suoi molteplici errori e contraddizioni. Normalmente, lui usa la tecnica del "blastaggio," consapevole di generare una forte reazione negativa. La mette in conto: è un modo di far passare un certo messaggio generando polemiche. Ma è una tattica che si può usare soltanto in attacco, non in difesa,
Il tweet si limita a dire esplicitamente una cosa che è ben nota a tutti quelli che lavorano nel campo della ricerca, anche se risulta sorprendente per il pubblico in generale. Non c'è quasi nessun controllo sulla validità dei dati e dei risultati pubblicati su una rivista scientifica, anche fra quelle di "alto livello." Vi passo, più sotto, una discussione sull'argomento da parte di "Birbo Luddynski." Scusate il linguaggio scatologico, ma la sua descrizione di come funziona la scienza è valida, perlomeno nel complesso.
In breve, comunque, Burioni ha ragione quando dice che il meccanismo di pubblicazione dei risultati di una ricerca si basa quasi completamente sulla fiducia. L'editore scientifico può solo decidere se il lavoro gli sembra adatto alla rivista, mentre i "referee" che sono incaricati di una forma di controllo qualità possono solo giudicare se le conclusioni degli autori sono consistenti con i dati riportati, e poco più.
Quindi, uno scienziato può imbrogliare? Certamente si. Come editore di una rivista e referee di tantissimi articoli mi sono capitati spesso casi in cui sospettavo un imbroglio, in alcuni casi con una evidenza lampante. Ma non è nei poteri dell'editore, e neppure del referee, di accusare un autore di aver falsificato i dati o di esserseli inventati di sana pianta senza prove precise. Per cui, anche un articolo sospetto può essere pubblicato senza grossi problemi. Forse poi qualcuno andrà a verificarne la correttezza rifacendo le misure, ma è una cosa rara.
Quindi non mi sono stupito quando uno degli epidemiologi più famosi al mondo, John Ioannidis, ha pubblicato un articolo con il titolo "perché la maggior parte dei risultati pubblicati sulle riviste scientifiche sono falsi." Secondo Ioannidis, un buon 50% degli articoli pubblicati mostrano segni di manipolazione dei dati, hanno difetti di impostazione, o le loro conclusioni non sono riproducibili. Altri hanno valutato una percentuale minore di falsificazioni e il dato si riferisce più che altro alla ricerca in campo medico. Ma, comunque sia, quando leggete un articolo scientifico, c'è una probabilità significativa che gli autori vi stiano imbrogliando.
Ma perché gli scienziati imbrogliano? Per tante ragioni: prestigio, carriera, soldi, e -- certe volte -- pura incompetenza. Alle volte anche per disperazione, quando la scelta per un giovane ricercatore è fra tirar fuori "qualcosa di pubblicabile" e il licenziamento. In ogni caso, pensate al conflitto di interesse che appare automaticamente quando uno scienziato accetta di essere pagato da una ditta farmaceutica per testare l'efficacia di uno dei loro farmaci. Come minimo, sono decine di milioni di euro in ballo che dipendono dai risultati del test. Vi stupireste se lo scienziato è tentato di dare un "aggiustatina" ai dati per far sembrare il farmaco più efficace di quanto non sia in realtà? Oppure che sia tentato di non controllare bene un set di dati troppo belli per essere veri? Oppure che faccia capire ai suoi sottoposti che si aspetta che venga fuori un certo risultato e non un altro?
Tornando a Burioni, nel suo tweet lui sta semplicemente cercando di giustificare qualcuna delle sue affermazioni avventate (per non dir di peggio) espresse durante la pandemia, dicendo "non è colpa mia, io mi fidavo di quello che leggevo sulla letteratura scientifica." Ma si sta dando la proverbiale zappata sui piedi.
In primo luogo perché arriva soltanto ora a dirci che i risultati scientifici vanno presi con un certo scetticismo, mentre prima ci presentava "La Scienza," ovvero le sue (di Burioni) affermazioni, come incontrovertibili. In secondo luogo perché si auto-accusa di non essere in grado di valutare criticamente quello che legge. Invece, un vero professionista di solito è in grado di "fiutare" un imbroglio quando lo vede. Dovrebbe perlomeno evitare di descrivere certe cose sospette come vere finché non ci sono prove indipendenti a sostegno. A meno che non ci sia un conflitto di interesse, ovviamente.
E così è andata. La scienza sta percorrendo la sua spirale di declino diventando sempre di più una struttura auto-referenziale che produce più che altro cartaccia inutile, quando non dannosa o addirittura letale. Prima o poi, i decisori e il pubblico dovranno anche accorgersi che li stanno imbrogliando, ma ancora ci vorrà un po' di tempo. A quel punto, ci vorrà una riforma radicale che mandi a casa gli imbroglioni, i profittatori, e gli incompetenti della scienza. Con il rischio di prendersela con quelli, e ce ne sono ancora tanti, che cercano di fare del loro meglio per essere scienziati onesti. Li si trovano specialmente in campi dove non girano tanti soldi, come l'astronomia, lo studio degli ecosistemi, e altri. Ma, anche lì, la corruzione avanza.
Nel frattempo, fatevi due risate (amare) con Birbo Luddynski. Come dicevo prima, è un po' esagerato nella sua critica, ma nel complesso ha ragione.
_____________________________________________________________________
La scienza è una montagna di merda!

di “Birbo Luddynski”
Premessa
La Scienza non è il metodo scientifico. La “Scienza” – maiuscolo tra virgolette – è oggi una istituzione, apolide e transnazionale, che si è appropriata fraudolentemente del metodo scientifico, ne ha fatto il suo monopolio esclusivo, e di questo si serve per taglieggiare la società – in proprio o per conto terzi – dopo essersi autoproclamata novella Chiesa della Certificazione del Vero [1].
Un elettricista che cerca di individuare un guasto o un cuoco che mira a perfezionare una ricetta, stanno applicando il metodo scientifico, senza neanche sapere cosa sia, e funziona! Ha sempre funzionato da migliaia di anni, prima cioè che qualcuno ne codificasse l’algoritmo, e continuerà a farlo, nonostante i moderni inquisitori.
Chi scrive non è un erudito, non cita fonti per convinzione ideologica, ma ha imparato in tenera età come si scrive “epistemologia”. Ha poi sguazzato per anni nei liquami dell’associazione a delinquere di cui sopra, fino a quando, senza esser riuscito ad assuefarsi al mefitico fetore, non ha trovato una onorevole via d’uscita. Popper, Kuhn, Feyerabend, sono stati tutti pensatori che avevano compreso appieno la perversione di certi meccanismi istituzionali, ma che non avrebbero neanche potuto immaginare che il marciume avrebbe dilagato in modo così incontrollato e tirannico nella società, fino al punto che uno scienziato possa raggiungere il potere di impedirti di uscire di casa, o di possedere un’automobile, o di importi di mangiare i vermi. A parte TK, lui aveva capito tutto, ma questo è un altro discorso.
In questo scritto non si parlerà del ruolo che ha la scienza nella società contemporanea, del suo progressivo divenire culto, del progressivo erodere degli spazi di libertà e di partecipazione civile in suo nome. Non si parlerà del rapporto coi media, e del potere che hanno i questi di far passare gli sproloqui di un mediocre professore borioso per verità acclarate. Non si parlerà quindi delle massime cariche dello stato che dichiarano guerra all’antiscienza, che dichiarano vittorie a plebisciti mai indetti, dove la gente viene portata alle urne a ricatti e bastonate.
Non si parlerà di come la “vera scienza” – ossia quella che afferisce al rispetto del metodo scientifico – sia violentata dal virologo internazionale e dai CTS del mondo, che prendono decisioni incoerenti, letteralmente a cazzo di cane, e pretendono che chiunque si adegui senza dubitare.
Non si parlerà neanche della tendenza a intavolare sterili dibattiti internettiani a partire dall’articolo che ci dà ragione sulla rivistona Lancette o Brianza Medical Journal, o Manure. Né della ovvia tendenza a fare raccolta ciliegie da parte del deboonker del momento. “Eh ma il professor Giannetti di Fortestano è un noto cialtrone, lol”. I perculatori d’ufficio dell’ipse dixit sono oggi dei meticolosi applicatori di una rigorosa gerarchia delle fonti e delle opinioni, basate su improbabili quanto rigorosi ranking di prestigio qualitativi, o peggio altrettanto improbabili quanto arbitrari indici bibliometrici quantitativi.
Qui troverete raccontato il motivo per cui la scienza non è ciò che dice di essere, e proprio per questo motivo ha assunto tale ruolo nella società.
Tutto quello che trovaterete qui scritto è ampiamente risaputo e documentato in libri, longform, articoli su settimanali divulgativi e persino articoli su riviste peer-reviewed (LOL). Googlate “publish or perish”, “reproducibility crisis”, “p-hacking”, “publication bias”, e decine di altri termini correlati. Io di fonti non ne fornisco, perché come ho detto è contrario alla mia ideologia. Il valore aggiunto di quanto vado a scrivere è una descrizione immediata, sicuramente partigiana e senza censure, dei meccanismi osceni che pervadono tutto il mondo scientifico, dal reclutamento degli studenti di PhD alle pubblicazioni.
Non c’è inoltre nessuna “vera scienza” da salvare, in contrapposizione a “lascienza”. La tesi di questo scritto è che la scienza è strutturalmente corrotta, e che i conflitti di interesse che la attanagliano sono così profondi e pervasivi, che solo una radicale ricostruzione – dopo la sua demolizione – dell’istituzione universitaria può salvare la credibilità di una ristretta cerchia di studiosi, quelli che cercano faticosamente, onestamente e umilmente, di aggiungere tasselli alla conoscenza del Creato.
Lo scienziato e la sua carriera
Per “scienziato” oggi si intende un ricercatore, impiegato a vario titolo presso università, centri di ricerca pubblici o privati, think tanks. Quella dello scienziato è una carriera completamente diversa da quella di ciascun lavoratore, e ricorda quella del cursus honorum della classe senatoria romana. Il cursus honorem della soia. Il CV di uno scienziato è diverso da quello di tutti gli altri lavoratori. Tra parentesi, la cosa più difficile per uno scienziato è compilare un CV intellegibile al mondo reale, qualora volesse tornare a guadagnarsi da divere onestamente fra i comuni mortali. Provate a fare un Europass dopo sei anni di post-doc LOL.
Lo scienziato è uno studente modello, nel corso di tutta la carriera scolastica prima e universitaria poi. Studente modello significa disciplinato, con voti negli ultimi percentili dei test standardizzati, e anche buone capacità relazionali. Riesce a farsi notare durante gli ultimi anni dell’università (cosiddetta “undergraduate”, che però stranamente in Italia è la magistrale o specialistica o come cazzo si chiama oggi), fino a trovare la raccomandazione (letteralmente) da parte di un professore per iscriversi a un programma di PhD, o dottorato, come si chiama fuori dall’Anglosfera. Il PhD è un programma universitario elitario, lungo dai tre ai sei anni a seconda del paese e della disciplina, dove viene addestrato a fare “lo scienziato”.
Durante il PhD nei primi anni segue corsi di altissimo livello tecnico, tenuti dai migliori professori del suo dipartimento, ai quali si affianca una prima fase di avviamento alla ricerca, sotto forma di “research assistant”, o RA. Questa fase, che sancisce il passaggio dalla “conoscenza consolidata” dei libri di testo alla “frontiera della ricerca scientifica”, avviene esplicitamente sotto la guida di un professore-mentore, che con buona probabilità seguirà lo studente dottorando durante la rimanente parte del corso di dottorato, e quasi sempre nel corso di tutta la carriera. L’agoghé della soia. Non tutti i dottorandi verranno ovviamente accoppiati a un mentore “vincente”, ma solo quelli più determinati, ambiziosi, e che mostrano vivacità nei corsi.
Nel corso di questa fase di RA, lo studente viene svezzato a quelle che sono le vere pratiche della ricerca scientifica. È una fase davvero cruciale, è il momento in cui lo studente passa dagli ideali romantico-prometeico-faustiani della scoperta del Vero, alle nottate passate a smanettare con dati che non hanno senso, fra errori nel codice e un generale sbigottimento di fronte al senso smarrito. Perché sto facendo tutto questo, perché devo trovare proprio QUEL risultato? Non è contrario a tutti gli schemini razionalisti che condividevo su facebook due anni fa, quando prendevo per il culo il terrapiattista di turno? Come sarebbe a dire che se la stima non supporta l’ipotesi allora devo cambiare la specificazione del modello? È a questo punto che in genere pone al mentore delle timide domande dal vago sapore “epistemologico”, che in genere vengono evase con supercazzole positiviste sulla scienza che prosegue per errori, o con un discorso che suona più o meno così: “Ti succederà di non capire. Ci sono due modi di non capire: non capire aspettando di capire, o non capire rompendo i coglioni. Scegli tu. A ottobre ti finisce la borsa.”
I più puri a questo punto cadono in depressione, dalla quale usciranno trovandosi un lavoro onesto, con o senza pezzo di carta. Gli arrivisti, gli psicopatici e gli ingenui Fachidioten andranno invece avanti come treni, inarrestabili nella loro sfolgorante carriera votata al prestigio.
Dopo la prima fase di RA, durante la quale contribuisce alle pubblicazioni del mentore – con o senza menzione tra gli autori – passa alla fase successiva, più matura, fatta di costruzione di una propria pipeline di ricerca, collaborazione da coautore con il mentore e i suoi altri coautori, partecipazione a conferenze, tessitura di una rete relazionale con altre università. Al coronamento di questa fase c’è il conseguimento del titolo di PhD, che però a questo punto non è niente altro che una formalità, dal momento che i conseguimenti del dottorando parlano da soli. La “dissertazione”, o “difesa” infatti non sarà altro che un seminario dove lo studente presenta il suo lavoro di maggior rilievo, già pubblicabile.
Ma ora lo studente è già lanciato: a seconda della disciplina e della fortuna, avrà già firmato un contratto da “assistant professor” in “tenure track”, o da “post-doc”. La sua carriera futura sarà quindi determinata esclusivamente dalla sua abilità nello scegliere i cavalli giusti, ossia i progetti di ricerca sui quali puntare. È infatti entrato nel mondo infernale del “publish or perish”, nel quale la sua probabilità di essere confermato “a vita“ dipende esclusivamente dal numero di articoli che riesce a pubblicare su riviste peer-reviewed “buone”. In molte scienze dure il limbo dei post-doc, durante i quali lo scienziato si sposta di contratto in contratto come un monaco errante, nell’impossibilità di vivere relazioni stabili, può durare anche dieci anni. La “tenure track”, ossia il periodo dopo il quale possono decidere se confermarti o meno, dura più o meno sei anni. Un ricercatore che riesce a diventare strutturato stabile in una università prima dei 35-38 anni anni può ritenersi fortunato. E questa non è affatto una peculiarità del sistema italiano.
Dopo l’agognato “posto fisso” da professore, può forse il ricercatore rilassarsi e mettersi a lavorare solo su progetti sensati, di qualità, che richiedono tempo e pazienza e che potrebbero anche non portare da nessuna parte? Può lavorare su progetti che possono anche sfidare il famoso consensus? Ha tempo di studiare per poter recuperare un po’ di visione di insieme? Sebbene l’istituto della “tenure”, cioè il posto fisso da professore, sia stato pensato proprio per questo, la risposta è no. Qualcuno lo fa anche, conscio di finire emarginato e ignorato dai suoi pari, nel dipartimento e fuori. Based, ma finisce nell’ultima stanza in fondo vicino al cesso, non vede una lira di fondi di ricerca, non lo invitano alle conferenze, e gli appioppano i dottorandi più sfigati per fare ricerca. Se simpatico viene trattato da zio eccentrico e preso bonariamente in giro, se antipatico viene prima odiato e poi ignorato.
Ma in generale, se sei sopravvissuto a dieci anni di publish or perish – e non tutti ci riescono – è perché ti piace farlo. Quindi continuerai a farlo, anche perché i premi sono ambiti. Aumenti di stipendio, named chairs, posto da editor delle riviste, fondi di ricerca, consulenze, inviti alle conferenze, grants milionari in qualità di principal investigator, interviste ai giornali e in televisione. Letteralmente soldi e prestigio. La corsa alle pubblicazioni non finisce, anzi a questo punto diventa sempre più spietata. E lo scienziato, ora di fatto un manager della ricerca, con decine di dottorandi e post-doc a disposizione come forza lavoro, perderà sempre più contatto con la materia della ricerca per interessarsi di politica accademica, soldi e pubbliche relazioni. Sarà il dottorando ora a “sbagliare” il codice al posto suo, fino a trovare il risultato sperato. Non dovrà neanche chiederglielo esplicitamente, nella maggior parte dei casi. Tanto comunque nessuno si accorge quasi mai di niente, perché a nessuno frega niente. Ma come, e il peer review?
Il peer-review
Migliaia di pagine sono state scritte su questo istituto, sui pregi, sui difetti, su come migliorarlo. È stato ridicolizzato e trollato a sangue, ma la conclusione recitata dagli alfieri della scienza è sempre la medesima: è il sistema migliore che abbiamo e ce lo dobbiamo tenere. Il che è in parte vero, ma la sua supposta aura di infallibilità è la principale responsabile dello stato penoso nel quale versa l’accademia. Vediamo come funziona.
Il nostro ricercatore Anon ha il suo bel Pdf scritto in Latex intitolato “The Antani Problem: is it Quintana or Setta?” (citazione boomer), e lo sottomette al Journal of Liquid Bullshit tramite la sua piattaforma web. Il Chief editor del JoLB prende il pdf, dà una occhiata veloce, e decide a quale associate editor smistarlo, in base all’argomento. L’editor prescelto dà un’altra occhiata veloce e decide se 1) mandare una breve lettera dove dice ad Anon che il suo lavoro è sicuramente bello e interessante ma unfortunately it is not a good fit for the Journal of Liquid Bullshit, I reccomend similar outlets such as Journal of Bovine Diarrhea, or Liquid Bovine Stool Review oppure 2) inviarlo ai referee. Ma fermiamoci un attimo.
Cos’è il Journal of Liquid Bullshit?
Il Journal of Liquid Bullshit è un “field journal” nell’ambito della disciplina generale “Bullshit” (Medicina, Fisica, Statistica, Scienze Politiche, Economia, Psicologia, etc), che si occupa del campo più specialistico Liquid Bullshit (Virologia, Astrofisica, Machine Learning, Regime Change, Labour Economics, etc). Non è una rivista gloriosa come Science o Nature, e non è una rivista prestigiosa nella disciplina (Lancet, JASA, AER, etc). Ma è una buona rivista, sulla quale pubblicano comunque regolarmente nomi importanti nel campo della merda liquida. Al contrario di quelle più prestigiose, legate in genere ad enti specifici o a editrici universitarie, la maggior parte di queste riviste è pubblicata (online, si intende) da editrici for profit, che campano vendendo a caro prezzo pacchetti di abbonamenti alle università.
Chi è il Chief editor? L’editor è una personalità di spicco nel campo del Liquid Bullshit. Sicuramente un Full Professor, minimo 55 anni, decine di pubblicazioni di rilievo, citatissimo, è stato keynote speaker in svariate conferenze annuali dell’American Association of Liquid Bovine Stools. Durante le conferenze ha costantemente un capannello di gente intorno.
Chi sono gli Associate editors?
Sono professori associati o full, con numerose pubblicazioni, anche se relativamente giovani. Ben connessi, ben lanciati. Il compito dell’associate editor è quello di gestire il manoscritto in tutte le sue fasi, dalla scelta dei referee alle decisioni circa le revisioni. L’AE è chi ha tutto il potere sul paper, non solo ovviamente per la decisione finale, ma anche per la scelta dei referee.
Chi sono i referee
I referee sono degli accademici, contattati formalmente dall’AE per valutare il paper e scrivere una breve relazione. Separatamente, inviano anche una raccomandazione privata all’AE sul destino del paper: accettazione, revisione, o rigetto. Il lavoro dei referee non è pagato, è tempo sottratto alla ricerca o molto spesso al tempo libero. Il referee riceve solo il paper, non ha alcun modo di valutare i dati o i codici, a meno che (cosa rarissima) gli autori non li mettano a disposizione sulle loro pagine web personali prima della pubblicazione. Difficile in ogni caso che il referee si metta a perdere tempo a smanettare. La valutazione richiesta al referee infatti è solo di natura metodologico-qualitativa, e non di merito. La valutazione “di merito” infatti spetterebbe alla “comunità scientifica”, che replicando il lavoro degli autori, sotto le stesse o altre condizioni sperimentali, ne giudicheranno la validità. Anche un bambino capirebbe che c’è un conflitto di interessi grande come una casa. Il referee infatti può attivamente sabotare il paper, e l’autore può tranquillamente sabotare i referee quando sarà il loro turno a giudicare. Infatti, quando i paper si scrivevano a macchina e viaggiavano per posta, il sistema usato era quello della review in “doppio cieco”. Dal manoscritto si toglieva il frontespizio: il referee non sapeva chi stava giudicando, e l’autore non sapeva chi fosse il referee. Da quando esiste internet, tuttavia, gli autori hanno trovato sempre più conveniente pubblicizzare i loro lavori in formato “workings paper”. Ci sono molte ragioni per farlo e non mi dilungo, ma la cosa è ormai talmente diffusa che ai referee basta una brevissima ricerca su google per trovare il working paper, e con esso i nomi degli autori. Ormai sempre più riviste hanno rinunciato a far finta di credere alla revisione in doppio cieco, e inviano ai referees il pdf completo di frontespizio. I referees non sono più quindi degli anonimi arbitri, soprattutto perché hanno dei forti conflitti di interesse. Ad esempio al referee può capitare tra le mani il paper di un suo amico o collega, o di uno sconosciuto che dà ragione – o torto – alla sua ricerca. Un referee può anche “rivelarsi” anni dopo all’autore, ad esempio davanti a un bicchiere, durante gli eventi alcolici nel corso di una conferenza, ovviamente in caso di report favorevole. Sai, sono stato referee del tuo paper al journal X. Può far comodo, se c’è una certa confidenza. Non dimentichiamo infatti che i referee è gente che a sua volta sta cercando di pubblicare i loro articoli su altri giornali, o addirittura gli stessi. E non tutti i referee sono uguali. Un “buon” referee è merce rara per un editor. Il buon referee è quello che risponde in tempo, e scrive report prevedibili. Ho conosciuto professori affermati che si vantavano di ricevere decine di paper al mese da referare “perché sanno che glieli rigetto tutti subito”.
Come funziona quindi questo processo di peer review?
Non dobbiamo immaginarci gli editor come gente avulsa dal mondo, ma con le mani estremamente in pasta. Un editor infatti ha un potere enorme, e non si diventa editor se non si dimostra di bramare a questo potere, oltre ad esserselo meritato, secondo le logiche perverse del cartello. Il potere enorme dell’editor consiste nell’influenzare la sorte di un paper in tutte le fasi della revisione. Può scegliere referee favorevoli o sfavorevoli a un paper: le faide scientifiche e i loro partecipanti sono note, e sono soprattutto note agli editors. Può anche schierarsi con il referee di minoranza e chiedere una revisione (o il rigetto).
Ogni ricercatore di alto livello sa quali sono gli editors amici, e sa quali possono essere i potenziali referee nemici più pericolosi. Gli articoli vengono spesso calibrati, cercando di leccare il culo all’editor o ai referee potenziali, strizzando l’occhio alle loro agende di ricerca. È in questo contesto infatti che si sviluppa il mercato delle vacche delle citazioni: se ho paura del referee Tizio, ne citerò più lavori possibili. Oppure altra strategia (valida per giornali minori e lavori di nicchia) è ignorarlo completamente, altrimenti l’editor neutrale potrebbe sceglierlo come referee semplicemente scorrendo la bibliografia. Molti referee inoltre, in fase di revisione, fanno di tutto per pompare le loro citazioni sostanzialmente spingendo gli autori a citare i loro lavori, anche se poco pertinenti. Ma questo accade su riviste minori. [2]
La cosa più rilevante da comprendere della natura del peer review, è come sia un processo a cui partecipano soggetti consapevolmente e strutturalmente in conflitto di interessi. La cosa divertente è che questo stesso sistema è anche usato per allocare i fondi di ricerca pubblici, come vedremo.
Il fatto che ogni tanto qualche articolo “scomodo” riesca a bucare il muro del peer review non deve ovviamente ingannare: il processo, seppur ben guidato, rimane ancora in parte casuale. Un referee può raccomandare l’accettazione inaspettatamente, e l’editor può farci ben poco. In ogni caso poco male: un articolo scomodo ogni tanto non contribuirà mai alla crazione del consensus, quello che fa comodo agli apparati finanziatori ultimi, e anzi dà all’osservatore esterno l’illusione che ci sia un dibattito franco.
Ma quindi si può davvero truccare i risultati di una ricerca e farla franca?
Generalmente sì, anche perché si bara a vari livelli, generalmente lasciandosi dietro vari schermi di plausible deniability, ossia espedienti che ti permettono di dire che ti sei sbagliato, che non lo sapevi, che non l’hai fatto apposta, che è stato il dottorando, che il cane ti ha mangiato i dati grezzi. Certo, nel raro caso che si venga scoperti non ci fai una bella figura, e il paper generalmente finirà “retracted”. Un discreto marchio di infamia sulla carriera di un ricercatore, che se però riesce a nascondere le prove della sua malafede conserverà comunque la cattedra, e tra qualche anno tutti si saranno dimenticati. Dopotutto son cose che fanno tutti: peccato, pietre, eccetera.
Ogni tanto, sempre più di frequente, capita qualche retraction grossa, dove si scopre che i dati di qualche lavoro ben pubblicato erano completamente inventati, e che i risultati erano troppo belli per essere veri. Questo accade quando qualche giovane emergente psicopatico esagera, e attira troppo l’attenzione su di sé. Questi casi estremi di frode totale sono sicuramente più numerosi di quelli scoperti, ma come detto non serve inventarsi i dati per trovare un risultato pubblicabile, basta pagare una scimmia che provi tutti i modelli possibili su tutti i sottoinsiemi possibili. La giustificazione a posteriori del perché hai escluso il sottoinsieme B si trova sempre. Volendo puoi anche ometterla, tanto se non hai pestato i piedi a nessuno è escluso che qualcuno si metta a fare le pulci al tuo lavoro. Addirittura nelle scienze sperimentali può capitare che nessuno sia riuscito a replicare gli esperimenti di paper importantissimi, e ci hanno messo quindici anni a scoprire che forse si erano inventati tutto. Andatevi a cercare su google “alzheimer scandal” LOL! Non c’è nessun incentivo reale nell’accademia a scoprire articoli farlocchi, se non letteralmente vantarsene su twitter.
I fondi per la ricerca
Per fare ricerca servono soldi. Non ci sono solo le attrezzature dei laboratori, che non sono comunque necessari in numerose discipline. C’è anche e soprattutto la forza lavoro. I laboratori e in generale la ricerca è infatti mandata avanti da gente sottopagata, cioè dottorandi e post-doc (in italia noti come “assegnisti”). Ma non solo, ci sono anche spese per software, acquisto dataset, viaggi per conferenze, seminari e workshop da organizzare, con gente da invitare e a cui pagare viaggio, albergo e cena in ristorante decente. Considerate l’importante lato PR di questo aspetto: invitare un professore importante, magari un editor, per una vacanzetta di due giorni e farselo “amico” può sempre tornare utile.
Oltre a tutto questo, c’è da considerare che in genere le università trattengono una quota dei grants vinti da ogni professore, e con questa quota ci fanno varie cose. Se il professore sfigato che non vince i grants deve cambiare la sedia, o il computer, o vuole andare a presentare a una conferenza sfigata dove non è invitato, dovrà andare col cappello in mano dal direttore di dipartimento a chiedere i soldi, che in buona parte proverranno dai grants vinti dagli altri. Non so come funzioni in Italia, ma nel resto del mondo è certamente così. Questo significa ovviamente che un professore che vince grants avrà più potere e prestigio in seno al dipartimento di uno che non li vince.
In breve, vincere fondi è un obiettivo fondamentale per ogni ricercatore ambizioso. Non vincere grants, anche per un professore con la tenure, implica diventare una sorta di reietto. A non vincere grants è quello strano, coi capelli arruffati, che ha l’ufficio in fondo al corridoio vicino al cesso. Ma come si vincono i grants?
I grants vengono dati da appositi enti – pubblici o privati – per l’erogazione di fondi alla ricerca, che pubblicano dei bandi, periodici o speciali. Il professore, o gruppo di ricerca, scrive un progetto di ricerca, nel quale dice cosa vuole fare, perché è importante, come intende farlo, con quali risorse e quanti soldi gli servono. La commissione a questo punto nomina dei referees “anonimi” esperti nel campo, che fanno la peer review sul progetto. Non ci vuole poco a capire che se sei un esperto nel campo, sai benissimo chi andrai a valutare. Se avete letto fino a qua, saprete anche benissimo che i referees hanno un gigantesco conflitto di interessi. Basta infatti una supercazzola per affossare il progetto della banda rivale, o favorire l’amico con il quale condividi la stessa agenda di ricerca, mentre nessuno avrà il coraggio di affossare il progetto del raìs del campo. La commissione infine valuterà il profilo accademico del richiedente, ovviamente contando il numero e il prestigio delle pubblicazioni, nonché il totemico H-index.
Abbiamo quindi un sistema dove pubblica chi ottiene i grants, e ottiene i grants chi pubblica. Il tutto governato da un inestricabile intreccio di conflitti di interesse, dove a risultare vincenti sono le connessioni informali – e in ultima istanza interessate – del singolo ricercatore. Connessioni informali che, ricordiamolo partono dal dottorato. Quello che è presentato come un sistema asettico, oggettivo e informale di valutazione meritocratica, assomiglia nella migliore delle ipotesi al sistema per assegnare l’appalto del rifacimento del parcheggio dei bus di un paesino dell’agro Pontino negli anni Ottanta.
L’agenda di ricerca
L’abbiamo nominata varie volte, ma cos’è davvero una agenda di ricerca? Sinteticamente possiamo dire che l’agenda di ricerca è un filone di ricerca in un certo sotto-campo di una sotto-disciplina, legato ad una ipotesi di partenza, e/o a una particolare metodologia. Questa ipotesi di partenza tenderà sempre a trovare conferma da chi porta avanti l’agenda. La metodologia invece verrà sempre presentata come risolutiva, e di gran lunga superiore alle alternative. Agenda di ricerca, per continuare con l’esempio di prima, potrebbe essere il rapporto fra colore e peso specifico degli escrementi bovini e produzione di latte. Oppure metodi non-parametrici per stimare la produzione di escrementi data la composizione della dieta.
Attorno all’agenda di ricerca vengono costruite o bloccate le carriere: un ricercatore con agenda “hot”, magari in un campo relativamente nuovo, avrà molte più probabilità di pubblicare bene, e quindi di prendere grants, e quindi di pubblicare bene. In genere si viene lanciati sull’agenda hot durante il dottorato, se l’advisor ti consiglia bene. Ad esempio può darsi che l’advisor abbia in mente un filone, ma non gli va di mettersi a imparare una nuova metodologia a 50 anni, quindi manda avanti il giovane coautore. Spesso quindi il prof cinquantenne, ormai “full professor”, si trova a diventare fra i leader di un filone di ricerca “d’avanguardia” senza averne mai davvero padroneggiato le metodologie e le tecnicalità, limitandosi dunque al lato manageriale e di marketing della questione.
Come già spiegato, intorno alle agende si formano delle vere e proprie bande, che agiscono per monopolizzare il dibattito sull’argomento, dando vita a un vero e proprio pseudo-dibattito controllato. Gli articoli “seminali” dei boss non si potranno mai demolire totalmente, semmai arricchire, espandere. Si potranno esplorare le questioni da un altro punto di vista, sotto altre dimensioni, utilizzare nuove tecniche di analisi, altri dati, che porteranno a conclusioni sempre via via diverse. La cosa chiave è che nessuno dirà mai “scusate raga ma qui stiamo perdendo tempo”. L’unico tempo perso nell’accademia è quello che non porta a pubblicazioni e quindi a grants.
Ma quindi chi detta l’agenda? La dettano – direttamente – i big players della ricerca, ossia i professori al top della carriera a livello internazionale, editors delle riviste più prestigiose. Indirettamente la dettano quindi i finanziatori ultimi della ricerca, diretti e indiretti: multinazionali e governi, sia direttamente che indirettamente, tramite l’azione delle lobby e dei vari potentati internazionali.
Il grosso equivoco alla base della scienza, e quindi della giustificazione del suo finanziamento di fronte all’opinione pubblica, è che questo incessante e caotico “ricercare per pubblicare” riesca comunque ad aggiungere tasselli alla Conoscenza. Ciò è largamente falso.
Infatti, le agende di ricerca non si parlano mai tra loro, e soprattutto non sembrano mai giungere ad una conclusione. Dopo anni di pseudodibattito l’agenda sarà stata talmente “arricchita” da centinaia di articoli pubblicati, che provare a dargli un senso sarebbe un lavoro duro e ingrato. Ingrato perché di fare questo lavoro non interessa a nessuno. Fondi sono stati spesi, e cattedre sono state prese. Il filone infatti prima o poi si secca: l’argomento smette di essere di moda, quindi di essere appetibile per le riviste top, passa via via su riviste minori, i dottorandi nuovi smetteranno di interessarsene, e se i leader del filone tengono alla carriera, passeranno ad altro. E ricomincia la giostra.
Le domande fondamentali poste all’inizio dell’agenda non avranno trovato risposte soddisfacenti, e le problematiche concettuali e metodologiche sollevate nel corso dello pseudo-dibattito accademico non saranno certamente state risolte. Un osservatore esterno che dovesse studiare tutta la letteratura di un filone di ricerca non potrà fare a meno di notare che i risultati “da portare a casa” sono ben pochi. Fra risultati inconcludenti, metodologie errate o applicate erroneamente, il contributo netto portato alla conoscenza è quasi sempre zero, e la risposta qualitativa, o “di buon senso”, rimane sempre la migliore.
Conclusioni
Abbiamo fin qui descritto lo scientificio. Il suo funzionamento, gli attori in esso coinvolti e il loro reclutamento. Abbiamo descritto come il conflitto di interessi – e la corruzione morale e sostanziale – governino ogni aspetto della professione accademica, che non è quindi in grado, nel suo complesso, di offrire alcun punto di vista oggettivo e imparziale, su nulla.
Il prodotto della scienza è una gigantesca montagna di merda: risposte sbagliate, incomplete, platealmente false e/o irrilevanti. Risposte a domande che nella maggior parte dei casi nessuno sano di mente avrebbe voluto porre. Una montagna di merda dove nessuno, fra quelli che vi sguazzano, sa un cazzo. Nessuno capisce un cazzo, e a domande malposte vengono date dietro pagamento risposte pilotate. Una montagna di merda dentro la quale mani febbrili cercano – e trovano – la giustificazione mistico-religiosa del potere, dell’arbitrio e della tirannide contemporanea.
Certo, ci sono le eccezioni. Certo, ci sta il prof. che è passato attraverso le maglie del sistema, e ora grazie alla posizione ha una piattaforma per dire qualcosa di interessante. Ma è una voce isolata, ridicolizzata, utilizzata per aizzare i consueti due minuti d’odio televisivi o social. Non c’è nessun bambino da salvare nell’acqua sporca. Il bambino è morto. Affogato nei liquami.
Il “dibattito accademico” è ormai un processo totalmente autoreferenziale, che non porta ad alcun risultato quantitativo (o qualitativo) tangibile. L’intera ricerca accademica non è altro che un gigantesco schema Ponzi per aumentare le citazioni, che servono a ottenere grants e pompare l’ego e il conto in banca – ma soprattutto l’ego – di carrieristi di professione.
La scienza come istituzione è un elefantiaco apparato ipertrofico, corrotto fino al midollo, la cui unica funzione – oltre a riprodurre incestuosamente sé stesso – è fornire la legittimazione del potere. Sicuramente un tempo era in grado di fornire anche la base della conoscenza tecnica necessaria alla riproduzione e al mantenimento del potere stesso. Oggi non più, la produzione inarrestabile della montagna di merda lo rende impossibile. Al più riesce a selezionare, nominalmente ed assegnando semplicemente un gettone di presenza attraverso le scuole più d’élite, i rampolli della nuova classe dirigente.
Quando qualcuno vi magnifica l’ultimo ritrovato della scienza, l’unica risposta possibile che si può dare è “non compro niente, grazie”. Se qualcuno vi dice che sta agendo “secondo scienza”, scappate.
[1] A consigliare Galilei di parlare di “ipotesi” fu Bellarmino. Per tutta risposta Galilei pubblicò il ridicolo “dialogo”, dove l’evidenza portata a sostegno delle sue affermazioni sull’eliocentrismo non era altro che una congettura, completamente sbagliata e senza alcun fondamento empirico. La posizione del Santo Uffizio fu letteralmente “dì quello che ti pare basta che non la spacci per Verità”. Galilei si è vendicato: ora dicono quello che gli pare e la spacciano per verità. Fonti? Cercatevele.
[2] Paradossalmente, nella fascia medio-bassa dei giornali, dove la competizione dei tagliagole è minima, si può trovare ancora qualche raro esempio di peer review fatto bene. Ad esempio una volta mi fu richiesto di referare un paper per un giornale minore, con il quale non avevo mai avuto nulla a che fare e del quale non conoscevo l’editor neanche indirettamente. Paper inviato senza frontespizio quindi anonimo, e stranamente non trovai il working paper online. Era oggettivamente una porcheria, e raccomandai il rigetto.
![]()